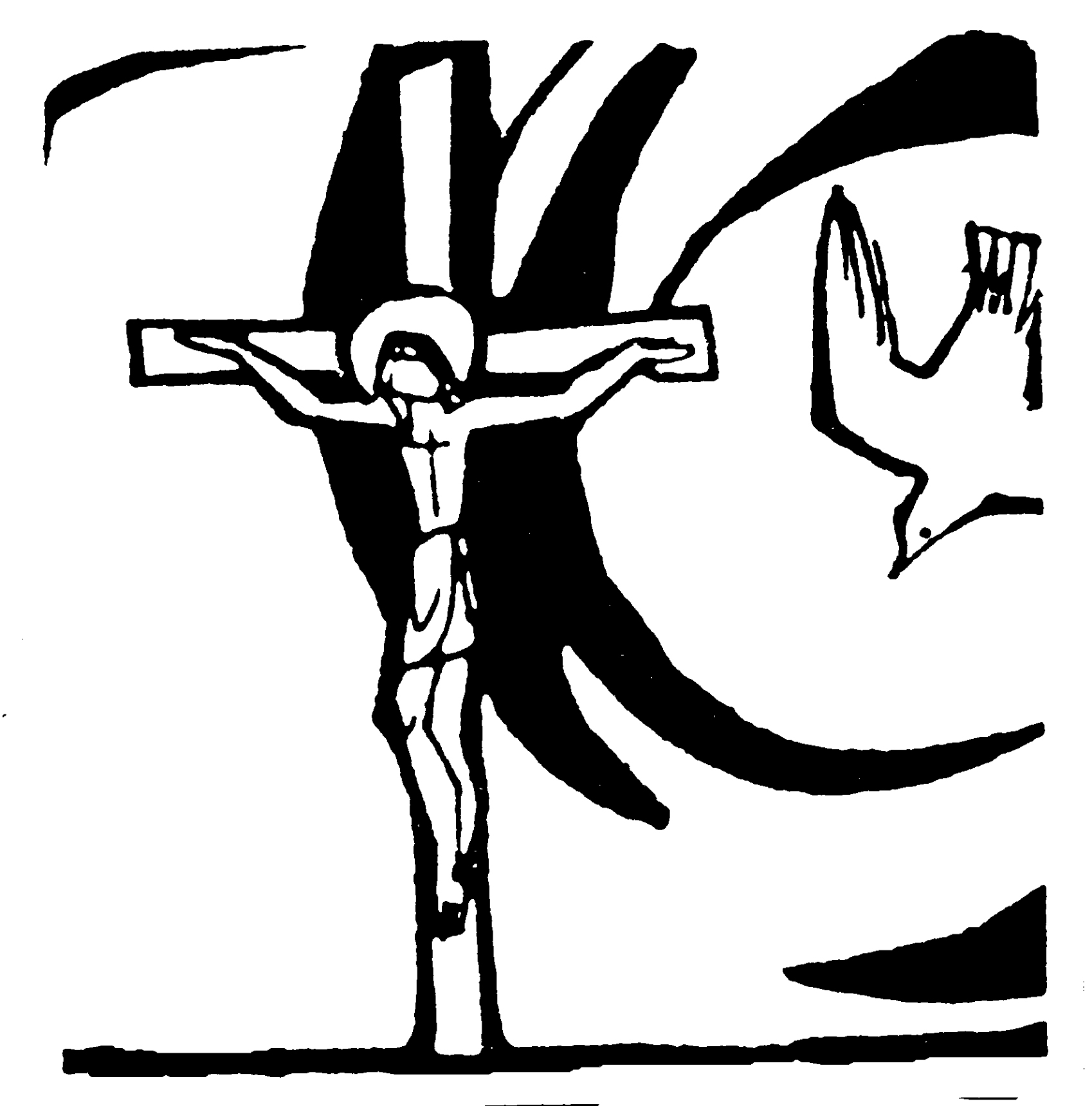Assenze
Padre Lorenzo Marcello Gilardi si assenta dalla casa religiosa di Gallarate (VA) per ministeri di formazione e per esercizi spirituali ignaziani. Nel «Calendario» la casella gialla indica il giorno corrente, le linee in verde i giorni di assenza con l'indicazione del luogo dove p. Gilardi si trova.
Orari delle confessioni
Il Sacramento della confessione o della penitenza si può celebrare in qualsiasi momento dell’anno e con qualsiasi sacerdote, che sia in comunione con il proprio Vescovo locale. Nelle chiese normalmente c’è un orario stabilito e ben esposto per le confessioni.
Si raccomanda di non celebrare il Sacramento della confessione durante la Celebrazione eucaristica a cui si partecipa, in modo da non interrompere la sua dinamica e vivere bene tutti i momenti della Santa Messa.
Padre Lorenzo M. Gilardi è disponibile per la Celebrazione del Sacramento della confessione nel Santuario del Sacro Cuore di Gallarate, dove attualmente risiede, e anche su appuntamento. Si può consultare la pagina «Assenze» per sapere dove egli si trova e poter concordare comodamente il giorno e l'orario.
Nel Santuario del Sacro Cuore di Gallarate p. Lorenzo M. Gilardi è presente per le confessioni in questi giorni e orari (2025):
FEBBRAIO
04 MARTEDI ORE 10:30-12:00
05 MERCOLEDI ORE 09:00-10:30
17 LUNEDI ORE 15:30-16:20
21 VENERDI ORE 10:30-12:00
GENNAIO
18 SABATO ORE 10:30-12:00
23 GIOVEDI ORE 10:30-12:00
28 MARTEDI ORE 10:30-12:00
DICEMBRE 2024
04 MERCOLEDI ORE 09:00-10:30
05 GIOVEDI ORE 10:30-12:00
06 VENERDI ORE 10:30-12:00
10 MARTEDI ORE 09:00-10:30
11 MERCOLEDI ORE 10:30-12:00
12 GIOVEDI ORE 10:30-12:00
13 VENERDI ORE 10:30-12:00
15 DOMENICA ORE 16:00-17:00
17 MARTEDI ORE 10:30-12:00
18 MERCOLEDI ORE 16:00-18:00
19 GIOVEDI ORE 16:00-18:00
23 LUNEDI ORE 10.30-12.00
24 MARTEDI ORE 16:00-18:00
NOVEMBRE
06 MERCOLEDI ORE 09:00-10:30
07 GIOVEDI ORE 10:30-12:00
12 MARTEDI ORE 10:30-12:00
14 GIOVEDI ORE 16:00-18:00
26 MARTEDI ORE 16:00-18:00
28 GIOVEDI ORE 16:00-18:00
29 VENERDI ORE 09:00-10:30
30 SABATO ORE 10:30-12:00
OTTOBRE
24 GIOVEDI ORE 16:00-18:00
28 LUNEDI ORE 16:00-18:00
31 GIOVEDI ORE 10:30-12:00 E 16:00-17:00
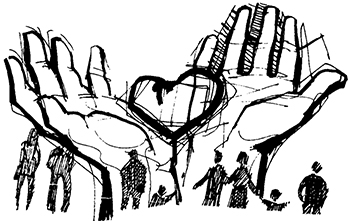
L’esame di coscienza generale
Nella dinamica dei suoi esercizi sant’Ignazio più volte invita a fare l’esame di coscienza. Tu avrai certamente sentito parlare di questa delicata forma di preghiera. Al catechismo per la prima comunione si insegna ai bambini a fare l’esame di coscienza quotidiano e l’esame in preparazione alla confessione e alla comunione. L’esame di coscienza di cui parla sant’Ignazio non è però solo un momento di riflessione per valutare un periodo della propria vita più o meno lungo, è una vera e propria forma di preghiera che avviene davanti a Dio. In questa forma di preghiera si offre a Dio la propria memoria, con tutte le sue facoltà e contenuti perché sia lui ad usarla per noi. Puoi provare anche tu ad offrire a Dio la tua memoria e uno spazio del tuo tempo per fare la «preghiera di esame» in questi giorni di esercizi spirituali.
♦
Tieni presente che puoi farla come un momento a parte, indipendente dal tempo fissato per la tua meditazione, ad esempio puoi dedicarvi quindici minuti nella pausa dopo il pranzo, o quando torni a casa dal lavoro o quando alla sera hai finito tutte le tue attività. Tuttavia, se vuoi, in questi giorni puoi fare come esame di coscienza anche la tua meditazione, cioè dedicare uno o più tempi di preghiera alla rilettura della tua vita, iniziando con uno dei brani biblici che ti ho consigliato e lasciando poi che lo Spirito porti a consapevolezza alcuni episodi della tua vita. In entrambi i modi, cerca di vivere sempre questo momento davanti a Dio, affinché sia lo Spirito Santo a guidare la tua memoria e ad illuminare con la sua luce la tua vita.
♦
L’esame di coscienza di sant’Ignazio non è finalizzato soltanto a cogliere i difetti e i peccati, come momento di autocorrezione, è soprattutto un momento di lode. Non si tratta infatti soltanto di un esame morale, ma di un esame spirituale, in cui cogliere i doni e i benefici ricevuti da Dio, lodarlo e ringraziarlo per essi. E’ un momento di «autocoscienza», in cui si prende vera consapevolezza dei doni ricevuti da Dio nel periodo che si intende esaminare. Vedrai allora che i doni che tu hai ricevuto sono molti di più dei peccati che tu hai commesso. Dalla consapevolezza dei doni, potrai passare all’autocoscienza di ciò che tu hai fatto per Dio, di come tu hai espresso la lode e la tua riconoscenza nei suoi confronti. Vedrai allora che tu hai fatto certamente qualcosa di buono per lui nella tua vita, anche se forse ti sembrerà qualcosa di sproporzionato in relazione a tutto quello che lui ha fatto per te. Pensa ad esempio al dono della vita, ai doni di salute, famiglia, formazione, alle persone che hai incontrato, alle molte occupazioni, ecc. A partire da questa «sproporzione» tra i doni ricevuti e l’attività da te svolta, potrai cominciare a vedere allora le tue omissioni. Non dimenticare che i nostri peccati più grandi sono proprio delle omissioni e delle mancanze di gratitudine. Di là potrai procedere a vedere le tue infedeltà, gli errori e i peccati in cui sei caduta/o.
♦
Ti riporto qui un brano degli esercizi di sant’Ignazio in cui lui tratteggia in breve il percorso di ogni esame di coscienza. Leggilo con calma e prova a seguire questi cinque punti nel tempo che dedicherai al tuo esame di coscienza. Non aver fretta, vedrai che spesso non riuscirai in un quarto d’ora a farli tutti e cinque. A volte l’esame si ferma sul primo o sul terzo punto; puoi allora concludere con una lode o un atto di dolore, pregando sempre il Padre tuo come la figlia o il figlio da lui molto amato.
MODO DI FARE L'ESAME GENERALE IN CINQUE PUNTI
1. Rendere grazie a Dio nostro Signore per i benefici ricevuti.
2. Chiedere la grazia di conoscere i peccati e di eliminarli.
3. Chiedere conto all'anima, dall'ora della levata fino al presente esame, di ora in ora o di tempo in tempo, prima dei pensieri, poi delle parole e poi delle opere.
4. Chiedere perdono a Dio nostro Signore per le mancanze.
5. Proporre di correggersi con la sua grazia.
Pater noster.
[ES 43]
Storia del sacramento della confessione
Nel Sacramento della confessione o della riconciliazione il credente rivive l’esperienza dell’incontro personale con l’amore misericordioso di Gesù, attraverso la sua comunità ecclesiale.
Il Sacramento della confessione ha una lunga storia. Possiamo farlo iniziare dagli incontri personali di Gesù, ad esempio con la donna samaritana (Gv 4, 1-42), in cui le dice «Hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito» (v. 18); con la donna adultera (Gv 8,1-11), dove dice: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più»; poi con la peccatrice della città venuta da lui a casa del fariseo (Lc 7,36-50), dove Gesù visto il suo amore le dice: «Ti sono perdonati e i tuoi peccati». Si possono ricordare anche altri episodi. Ad esempio, il colloquio con Nicodemo (Gv 3,1-21), dove Gesù dice: «Se uno non nasce da acqua e da Spirito non può entrare nel regno di Dio»; le parole di Gesù a Pietro, che gli domandava quante volte dovesse perdonare suo fratello e Gesù gli disse: «Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,22). Infine, si devono ricordare le parole di Gesù risorto ai discepoli durante il dono dello Spirito Santo: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi» (Gv 20,23).
Oggi l’incontro con Gesù nel mistero sacramentale avviene in modo semplice: si inizia con una preghiera del sacerdote e del fedele, poi il fedele riconosce e dichiara i suoi peccati, il sacerdote che l’accoglie e l’ascolta, riconoscendo il suo sincero pentimento, gli dà l’assoluzione, a nome di Dio e della Chiesa, e una penitenza riparatrice, che il fedele farà, ritornando nella grazia di Dio.

Il rapporto tra penitente e sacerdote è personale ed è tutelato dal segreto sacramentale, che il sacerdote non può assolutamente rompere, neppure al costo della propria vita. Il segreto riguarda sia le colpe accusate, sia l’identità del penitente, sia la penitenza da fare.
Il modo con cui si svolge il sacramento della confessione è cambiato nel tempo: «La penitenza non è sempre stata così; questa penitenza auricolare, così com’è giunta a noi, ha avuto la sua formulazione a partire dal XII e XIII secolo, quando si è cominciato a considerare l’intenzione e le motivazioni interiori dell’agire umano come decisive per considerare e valutare l’uomo e il suo comportamento. L’odierna penitenza auricolare è espressione di questa nuova maniera d’intendere l’uomo; tutta l’attenzione è posta sulla coscienza del penitente e sul suo mondo interiore, in modo da valutare la sua azione e il suo pentimento in base alle motivazioni interiori del penitente stesso» (da ENRICO MAZZA, La liturgia della penitenza nella storia. Le grandi tappe, EDB, Bologna, 2013, p. 5).
La storia del sacramento della penitenza è stata studiata e suddivisa in modi e in tappe. Per Cyrille Vogel, uno studioso della storia della penitenza occidentale, essa si è sviluppata in quattro momenti principali:
1. L’epoca paleocristiana, con la penitenza antica;
2. L’alto medioevo, con la penitenza tariffata secondo la gravità dei peccati;
3. Il basso medioevo, fino al XII secolo, con la penitenza tariffata per i peccati occulti e con la penitenza pubblica per le colpe pubbliche;
4. Dopo il XII secolo, con la penitenza privata sacramentale, il pellegrinaggio di penitenza e la penitenza pubblica solenne per le colpe pubbliche.
(in C. VOGEL, Il peccatore e la penitenza nel medioevo, LDC, Leumann, 1970, p. 30; citato in E. MAZZA, cit., p. 10).
Un altro studioso, il domenicano Marie-François Berrouard, ha approfondito i primi sei secoli, cioè il primo periodo di quelli indicati da Cyrille Vogel, e indica altre quattro tappe evolutive iniziali:
1. Nei primi due secoli, I e II, nelle assemblee dei convertiti la penitenza è un fatto eccezionale;
2. Con il III secolo, la penitenza diventa una della istituzioni della Chiesa e si va definendo una dottrina;
3. Dal IV secolo alla metà del V, la penitenza diventa un fatto giuridico;
4. Dalla metà del V secolo la penitenza viene sempre più definita canonicamente.
(in M.-F. BERROUARD, «La pénitence publique durant les six premiers siècles. Histoire et sociologie», in La Maison-Dieu (1974) 118, 92-130; citato in E. MAZZA, cit., p. 11).
Oggi il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione è descritto e definito dal Catechismo della Chiesa Cattolica (cfr. CCC 1422-1498). Esso è inserito nei Sacramenti di guarigione, insieme alla Unzione degli infermi.
Al canone 1423, citando la costituzione dogmatica Lumen Gentium, si dice:
«Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l’esempio e la preghiera».
Al canone 1424 si espongono i diversi modi con cui viene chiamato questo mistero sacramentale e si dice che:
E’ chiamato Sacramento della conversione, poiché realizza sacramentalmente l’appello di Gesù alla conversione, il cammino di ritorno al Padre da cui ci si è allontanati con il peccato.
E’ chiamato Sacramento della Penitenza poiché consacra un cammino personale ed ecclesiale di conversione, di pentimento e di soddisfazione del cristiano peccatore.
E’ chiamato Sacramento della confessione poiché l’accusa, la confessione dei peccati davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In senso profondo esso è anche una «confessione», riconoscimento e lode della santità di Dio e della sua misericordia verso l’uomo peccatore.
E’ chiamato Sacramento del perdono poiché, attraverso l’assoluzione sacramentale del sacerdote, Dio accorda al penitente il perdono e la pace.
E’ chiamato Sacramento della Riconciliazione perché dona al peccatore l’amore di Dio che riconcilia: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Colui che vive dell’amore misericordioso di Dio è pronto a rispondere all’invito del Signore: «Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello» (Mt 5,24).
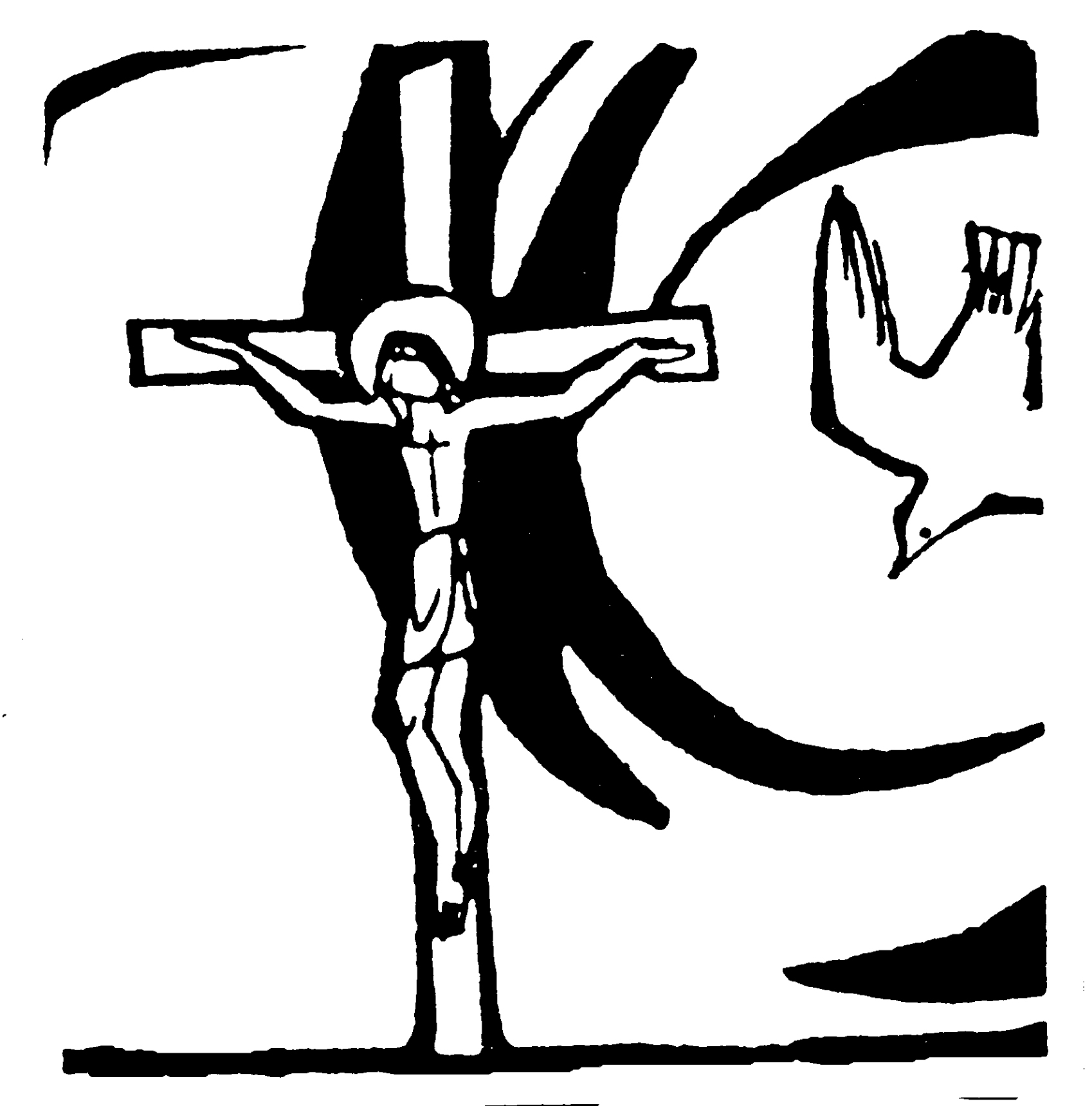
Storia del sacramento della confessione
Nel Sacramento della confessione o della riconciliazione il credente rivive l'esperienza dell'incontro personale con l'amore misericordioso di Gesù, attraverso la sua comunità ecclesiale.
Il Sacramento della confessione ha una lunga storia. Possiamo farlo iniziare dagli incontri personali di Gesù, ad esempio con la donna samaritana (Gv 4, 1-42), in cui le dice «Hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito» (v. 18); con la donna adultera (Gv 8,1-11), dove dice: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più»; poi con la peccatrice della città venuta da lui a casa del fariseo (Lc 7,36-50), dove Gesù visto il suo amore le dice: «Ti sono perdonati e i tuoi peccati». Si possono ricordare anche altri episodi. Ad esempio, il colloquio con Nicodemo (Gv 3,1-21), dove Gesù dice: «Se uno non nasce da acqua e da Spirito non può entrare nel regno di Dio»; le parole di Gesù a Pietro, che gli domandava quante volte dovesse perdonare suo fratello e Gesù gli disse: «Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette» (Mt, 18,22). Infine, si devono ricordare le parole di Gesù risorto ai discepoli durante il dono dello Spirito Santo: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi» (Gv 20,23).
Oggi l'incontro con Gesù nel mistero sacramentale avviene in modo semplice: si inizia con una preghiera del sacerdote e del fedele, poi il fedele riconosce e dichiara i suoi peccati, il sacerdote che l'accoglie e l'ascolta, riconoscendo il suo sincero pentimento, gli dà l'assoluzione, a nome di Dio e della Chiesa, e una penitenza riparatrice, che il fedele farà, ritornando nella grazia di Dio.

Il rapporto tra penitente e sacerdote è personale ed è tutelato dal segreto sacramentale, che il sacerdote non può assolutamente rompere, neppure al costo della propria vita. Il segreto riguarda sia le colpe accusate, sia l'identità del penitente, sia la penitenza da fare.
Il modo con cui si svolge il sacramento della confessione è cambiato nel tempo: «La penitenza non è sempre stata così; questa penitenza auricolare, così com'è giunta a noi, ha avuto la sua formulazione a partire dal XII e XIII secolo, quando si è cominciato a considerare l'intenzione e le motivazioni interiori dell'agire umano come decisive per considerare e valutare l'uomo e il suo comportamento. L'odierna penitenza auricolare è espressione di questa nuova maniera d'intendere l'uomo; tutta l'attenzione è posta sulla coscienza del penitente e sul suo mondo interiore, in modo da valutare la sua azione e il suo pentimento in base alle motivazioni interiori del penitente stesso» (da ENRICO MAZZA, La liturgia della penitenza nella storia. Le grandi tappe, EDB, Bologna, 2013, p. 5).
La storia del sacramento della penitenza è stata studiata e suddivisa in modi e in tappe. Per Cyrille Vogel, uno studioso della storia della penitenza occidentale, essa si è sviluppata in quattro momenti principali:
1. L'epoca paleocristiana, con la penitenza antica;
2. L'alto medioevo, con la penitenza tariffata secondo la gravità dei peccati;
3. Il basso medioevo, fino al XII secolo, con la penitenza tariffata per i peccati occulti e con la penitenza pubblica per le colpe pubbliche;
4. Dopo il XII secolo, con la penitenza privata sacramentale, il pellegrinaggio di penitenza e la penitenza pubblica solenne per le colpe pubbliche.
(in C. VOGEL, Il peccatore e la penitenza nel medioevo, LDC, Leumann, 1970, p. 30; citato in E. MAZZA, cit., p. 10).
Un altro studioso, il domenicano Marie-François Berrouard, ha approfondito i primi sei secoli, cioè il primo periodo di quelli indicati da Cyrille Vogel, e ne indica quattro tappe evolutive iniziali:
1. Nei primi due secoli, I e II, nelle assemblee dei convertiti la penitenza è un fatto eccezionale;
2. Con il III secolo, la penitenza diventa una della istituzioni della Chiesa e si va definendo una dottrina;
3. Dal IV secolo alla metà del V, la penitenza diventa un fatto giuridico;
4. Dalla metà del V secolo la penitenza viene sempre più definita canonicamente.
(in M.-F. BERROUARD, «La pénitence publique durant les six premiers siècles. Histoire et sociologie», in La Maison-Dieu (1974) 118, 92-130; citato in E. MAZZA, cit., p. 11).
Oggi il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione è descritto e definito dal Catechismo della Chiesa Cattolica (cfr. CCC 1422-1498). Esso è inserito nei Sacramenti di guarigione, insieme alla Unzione degli infermi.
Al canone 1423, citando la costituzione dogmatica Lumen Gentium, si dice:
«Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera».
Al canone 1424 si espongono i diversi modi con cui viene chiamato questo mistero sacramentale e si dice che:
E' chiamato Sacramento della conversione, poiché realizza sacramentalmente l'appello di Gesù alla conversione, il cammino di ritorno al Padre da cui ci si è allontanati con il peccato.
E' chiamato Sacramento della Penitenza poiché consacra un cammino personale ed ecclesiale di conversione, di pentimento e di soddisfazione del cristiano peccatore.
E' chiamato Sacramento della confessione poiché l'accusa, la confessione dei peccati davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In senso profondo esso è anche una «confessione», riconoscimento e lode della santità di Dio e della sua misericordia verso l'uomo peccatore.
E' chiamato Sacramento del perdono poiché, attraverso l'assoluzione sacramentale del sacerdote, Dio accorda al penitente il perdono e la pace.
E' chiamato Sacramento della Riconciliazione perché dona al peccatore l'amore di Dio che riconcilia: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Colui che vive dell'amore misericordioso di Dio è pronto a rispondere all'invito del Signore: «Va' prima a riconciliarti con il tuo fratello» (Mt 5,24).